PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Il paesaggio che oggi osserviamo al Vesuvio è il risultato di grandi sconvolgimenti geologici che hanno interessato la Piana Campana a partire da alcuni milioni di anni fa. Tra gli effetti di questi eventi geologici c’è la nascita del vulcano, che si fa risalire a circa 400.000 anni fa. La posizione geografica del Vesuvio, le terre fertili arricchite dai minerali contenuti nelle lave, insieme allo splendore dei luoghi hanno determinato la colonizzazione di quest’area già a partire da ,alcuni secoli dopo la nascita di Cristo. In quest’epoca furono i Greci e poi i Romani a stabilire le prime colonie alle falde del Vesuvio. Le colonie romane stabilitesi tra Pompei, Ercolano, Stabia ed Oplonti saranno costrette ad abbandonare il Vesuvio in seguito alla catastrofica eruzione del 79 d.C. A questa seguirà nel 472 d.C. un’altra eruzione esplosiva di grande energia. Il vulcano rimarrà poco abitato almeno fino ad alcune centinaia di anni dopo l’evento del 472. Tra il 1631 ed il 1944 le abitazioni alle falde del vulcano rimangono sempre a debita distanza dal cratere, grazie all’attività persistente che il vulcano mostrava in quest’ arco di tempo.
Il vulcanismo nell’area del Somma-Vesuvio è stato attivo a partire da 400.000 anni, come indicato dalla presenza di lave e tufi intercalati a sedimenti marini, carotati nella porzione sud-orientale del vulcano ad una profondità di 1350 m. La successione di vulcaniti e sedimenti marini è ricoperta dall’Ignimbrite Campana, eruttata dai Campi Flegrei 37.000 anni fa, che determinò la quasi completa emersione della Piana Campana. L’accrescimento del Monte Somma cominciò subito dopo la deposizione dell’Ignimbrite Campana e fu determinato dal progressivo accumulo di lave e scorie prodotte da attività effusiva ed esplosiva di bassa energia che raggiunse un’altezza stimata di circa 2000 m s.l.m.. La più vecchia eruzione pliniana avvenuta al Somma-Vesuvio è quella che ha prodotto le Pomici di Base che avvenne 18.300 anni fa e determinò l’inizio del collasso vulcano-tettonico del grosso cono del Monte Somma e la formazione della caldera. Dopo questa eruzione l’attività del vulcano è stata caratterizzata da altre 3 eruzioni pliniane, avvenute, 8.000 (Pomici di Mercato), 3.800 anni fa (Pomici di Avellino) e nel 79 d.C. (Pomici di Pompei), rispettivamente, da numerose eruzioni subpliniane, e fasi di attività di bassa energia a condotto aperto, con eruzioni stromboliane ed effusioni laviche. L’eruzione fu seguita da due eruzioni subpliniane, avvenute nel 472 e nel 1631 d.C. e da periodi di attività a condotto aperto, con eruzioni effusive ed esplosive di bassa energia (stromboliane). La deposizione dei prodotti da caduta delle eruzioni pliniane e subpliniane sui versanti appenninici ha generato spesse sequenze di livelli di ceneri e pomici separate da paleosuoli che ricoprono, in modo discontinuo le sequenze di rocce che costituiscono i rilievi appenninici. Le sequenze piroclastiche, nel tempo, sono state interessate da numerosi episodi di rimobilizzazione ad opera delle acque superficiali, con diffusa generazione di depositi vulcanoclastici derivanti da alluvioni, debris flows che hanno formato ai piedi dei versanti diverse generazioni di depositi alluvionali.
Il versante vesuviano e quello sommano differiscono notevolmente dal punto di vista naturalistico, il primo è più arido, in gran parte riforestato per impedire fenomeni franosi e presenta le caratteristiche successioni vegetazionali della macchia mediterranea; il versante del Somma, più umido, è caratterizzato dalla presenza di boschi misti.
Sulle colate laviche più recenti la colonizzazione vegetale inizia ad opera dello Stereocaulon vesuvianum, un lichene coralliforme dal tipico aspetto grigio e filamentoso. Il lichene ricopre interamente la lava del 1944 e la colora di grigio facendole assumere riflessi argentati nelle notti di luna piena. Sulle colate più antiche allo Stereocaulon vesuvianum 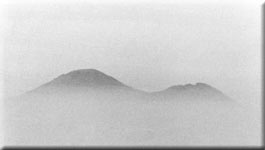 si affiancano le altre specie pioniere, tra cui la Valeriana rossa, l'Elicriso, l'Artemisia e la Romice rossa e di estesi ginestreti, che imprimono un aspetto caratteristico ai versanti del Vesuvio, soprattutto durante le fioriture; sono presenti 3 specie di ginestra: la Ginestra dei carbonai, la Ginestra odorosa e la Ginestra dell'Etna, endemita etneo introdotto sul Vesuvio dopo l’eruzione del 1906.
si affiancano le altre specie pioniere, tra cui la Valeriana rossa, l'Elicriso, l'Artemisia e la Romice rossa e di estesi ginestreti, che imprimono un aspetto caratteristico ai versanti del Vesuvio, soprattutto durante le fioriture; sono presenti 3 specie di ginestra: la Ginestra dei carbonai, la Ginestra odorosa e la Ginestra dell'Etna, endemita etneo introdotto sul Vesuvio dopo l’eruzione del 1906.
Sul versante sud-occidentale del Vesuvio, l’originale vegetazione mediterranea è stata in parte sostituita da pinete impiantate a partire dalla seconda metà del 1800 tra i 300 e i 900 metri. Esse sono costituite prevalentemente da Pino marittimo, da Pino domestico e da Pino d’aleppo; unito alla quercia tipica dell’area mediterranea, il Leccio. Nella lecceta e nella pineta il sottobosco è costituito da Corbezzolo, Lentisco, Terebinto Rosa selvatica, Asparago selvatico, Edera, ecc...
La macchia mediterranea dei versanti vesuviani si caratterizza per un’elevata diversità floristica. Oltre al leccio sono presenti, infatti, arbusti sclerofilli sempreverdi quali il Mirto, l'Alloro, il Viburno. Alle sempreverdi si associano anche in alcune zone piante caducifoglie xerofile quali la Roverella, l'Albero di Giuda e l'Acero.
Lo strato più basso della macchia mediterranea è rappresentato da piante profumate e diverse varietà di erbe officinali quali il Rosmarino, la Salvia, l’Origano, ecc…
Le pendici settentrionali del Monte Somma, più umide, sono, invece, coperte da ampi castagneti fino a quota 900 mt; a quote superiori prevalgono, invece, i boschi misti di latifoglie costituiti da Castagno, Carpino nero, Orniello, Ontano, ecc…. Da annoverare anche la presenza di alcuni nuclei sparsi di Betulla, specie relitta di boschi mesofili dell’era glaciale, che si rinvengono sul Monte Somma e nella Valle del Gigante.
Il sottobosco è particolarmente ricco: Dondolino, Pungitopo, Biancospino, Ligustro e numerose specie di felci e Crassulacee tra cui l’Ombelico di Venere e la Borracina ecc..
Tra la primavera e l’estate fioriscono in territorio, infine, 23 specie di orchidee selvatiche; le più facilmente riconoscibili sono la Orchis papillonacea e la Orphys sphegodes.
Anche la fauna è stata protagonista, come le associazioni vegetali, di ripetute colonizzazioni a seguito delle cicliche eruzioni del Vesuvio, ma la vicinanza alla fascia costiera, il fatto di essere l'unico complesso montuoso situato al centro della pianura nolana, le favorevoli condizioni climatiche e la grande diversità ambientale, hanno contribuito a consentire, in un territorio di modesta estensione, l’insediarsi di un interessante popolamento faunistico.
I Vertebrati: Anfibi e rettili.
Gli anfibi presenti sono il Rospo smeraldino e la Rana verde; il primo è piuttosto diffuso nel territorio del Parco alle quote medio-basse, la seconda è invece molto localizzata, laddove sono presenti pozze o vasche artificiali. Tra i rettili sono degni di nota il Cervone ed il Saettone, entrambi molto rari, mentre la specie più diffusa è il Biacco, che frequenta quasi tutti gli habitat, compresi quelli antropizzati. E’ presente anche la Vipera comune, soprattutto negli ambienti forestali.
Mammiferi
I mammiferi più comuni nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio sono gli insettivori e i roditori. Tra i primi si segnala il Riccio, presente in tutto il territorio protetto, il Mustiolo, la Crocidura minore, la Talpa romana, mentre tra i secondi sono presenti il Ghiro, il Topo quercino, il Topo selvatico ed il Moscardino, soprattutto negli ambienti boscati del versante sommano. Due le specie di lagomorfi accertate: il Coniglio selvatico, protagonista di una notevole espansione demografica, e la Lepre europea, presente soprattutto alle quote medio-alte con una discreta densità di popolazione. I predatori sono rappresentati dalla Volpe, diffusa in tutti gli habitat del territorio vesuviano, compresi quelli densamente antropizzati, la Faina, anch'essa presente in tutto il territorio, prediligendo però gli ambienti forestali, e la Donnola, comune soprattutto nel versante sommano.
Uccelli
La classe degli uccelli rappresenta sicuramente il taxon più ricco del Parco nazionale del Vesuvio; a parte le specie che nidificano e svernano sul territorio, il complesso del Somma-Vesuvio, essendo posto lungo le rotte migratorie dell'avifauna del Paleartico occidentale, ed essendo l’unico rilievo montuoso di una certa importanza all’interno di una vasta area pianeggiante, riveste una fondamentale importanza ed un riferimento sicuro per numerosi uccelli migratori. Tra questi vale la pena citare il Falco di palude, il Gruccione, l'Averla capirossa. Tra le specie nidificanti citiamo quelle della Poiana, del Falco pecchiaiolo, dello Sparviere, del Gheppio e del Pellegrino.
|
|
|
|
|
|
|
|